Claudio Mutti è un accademico italiano — musulmano, tradizionalista ed eurasiatista. Continua a dirigere la rivista Eurasia Rivista. Mutti, la cui strada si è incrociata con quella di numerose figure di rilievo, è uno dei pensatori d’eccezione che hanno assistito in prima persona ai momenti cruciali della nostra epoca; questa è la sua prima intervista realizzata in Turchia. Abbiamo discusso di un’ampia gamma di temi che spazia da Nietzsche alla geopolitica, da Codreanu all’eurasianismo, dall’Islam all’idea di un’unità mediterranea.
Per i nostri lettori in Turchia, potrebbe raccontarci qualcosa di sé per coloro che non la conoscono? In che modo la sua conversione all’Islam e il suo rapporto con la scuola tradizionale hanno plasmato il suo percorso intellettuale e spirituale? In che modo Julius Evola e la scuola tradizionalista hanno influenzato il suo percorso filosofico?
Ho praticato la religione cattolica fino all’età di quindici anni, quando l’abolizione della lingua liturgica latina e il cambiamento dei riti religiosi mi indussero a ricercare altre vie di approccio al sacro. In questa ricerca, mi furono del massimo aiuto i cosiddetti “maestri della Tradizione”, in particolare Julius Evola e René Guénon. La magistrale opera evoliana Rivolta contro il mondo moderno mi presentò l’Islam come una “tradizione di livello superiore non solo all’ebraismo, ma anche alle credenze che hanno conquistato l’Occidente”; l’opera di René Guénon fu per me la bussola per un ulteriore approfondimento delle dottrine tradizionali e dell’Islam in particolare. Passai dalla teoria alla pratica pronunciando la shahada all’età di trentatré anni.
Cosa ti ha spinto a scrivere il libro Nietzsche e l’Islam, e hai affrontato le idee di Nietzsche in modo simile alle interpretazioni di Muhammad Iqbal?
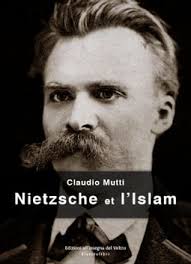
Secondo Muhammad Iqbal le esigenze fondamentali espresse dal pensiero di Nietzsche trovano piena soddisfazione nella visione islamica. La Gestalt (figura archetipica) alla quale Nietzsche dà il nome di Übermensch (Superuomo) si sublima e si perfeziona nella nozione islamica di “servo di Dio”. Infatti il “Superuomo” islamico, quell’uomo perfetto (al-insan al-kamil) che è esemplificato dal Profeta Muhammad, nel Corano (XVII, 1) è chiamato ‘abd, “servo” nel momento della sua massima esaltazione, ossia quando viene trasportato verso il Trono divino. Übermensch è dunque, secondo Iqbal, colui che pienamente ed attivamente identifica la propria volontà con la Volontà divina. D’altronde nel pensiero di Nietzsche vi sono altre nozioni fondamentali che, come quella di Übermensch, trovano una puntuale rispondenza nella dottrina dell’Islam. Tale, ad esempio, è il caso della formula dell’amor fati, perno centrale della concezione nietzschiana della vita. Caratteristica dell’Islam è infatti la consapevolezza della totale dipendenza della manifestazione dal suo Principio divino: di qui la fiduciosa accettazione, da parte del muslim, di quanto avviene nell’universo. E questa posizione, che non esclude affatto la responsabilità del singolo e si accorda perfettamente con l’azione, potrebbe venire a buon diritto definita mediante un riferimento all’espressione nietzschiana amor fati, specialmente quando la serena accettazione del decreto divino (fatum) si traduce in amore per Allâh.
Corneliu Zelea Codreanu è una figura importante nella storia rumena, in particolare come fondatore della Guardia di Ferro. In che modo le sue idee e azioni influenzano o si relazionano con le tue opinioni sul nazionalismo e il tradizionalismo?
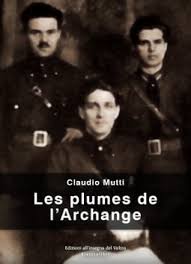
La Guardia di Ferro (la Legione Arcangelo Michele), il cui nazionalismo e tradizionalismo consistettero in uno stretto rapporto con le tradizioni del popolo romeno, non fu un partito politico nel senso moderno del termine, ma un movimento animato da un afflato religioso, quasi mistico; non a caso furono numerosi i sacerdoti ortodossi che militarono nelle sue file. L’etica legionaria può essere definita ascetica e cavalleresca, in quanto ispirata a un ideale di sacrificio, di superamento di sé e di servizio del popolo. Nel suo libro “Per i legionari” Corneliu Codreanu scrive che la Legione deve essere più una scuola e un esercito che non un partito politico e che da questa scuola dovrà uscire un “uomo nuovo”, cioè un uomo con le qualità di eroe. Anche Julius Evola, dopo un lungo colloquio col Capitano, scrisse che “il compito del Movimento non è di formulare nuovi programmi, ma di creare, di progettare un uomo nuovo, un modo nuovo di essere.
Il suo interesse per la geopolitica è legato al suo pensiero tradizionalista, o ci sono state ragioni storiche o intellettuali specifiche che l’hanno condotto a questo?
Una riflessione di René Guénon sulla “geografia sacra” e sul simbolismo geografico mi ha indotto a chiedermi se sia possibile applicare anche alla geopolitica la celebre affermazione di Carl Schmitt, secondo cui “tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati”. Ebbene, a mio parere alcune caratteristiche nozioni geopolitiche potrebbero essere considerate “concetti teologici secolarizzati”. Qui mi limito ad un solo esempio. La parola latina limes, acquisita dal lessico geopolitico attuale (al punto che una rivista italiana di geopolitica si intitola proprio con questa parola), indicava in origine una linea divisoria tracciata fra le porzioni di terreno assegnate ai coloni, finché il suo valore si allargò a indicare una strada militare, anzi l’insieme stesso delle fortificazioni ai confini dell’impero, là dove i confini non erano segnati dal mare o da un fiume. Supremo protettore del limes era il dio Terminus, al quale Ovidio si rivolge dicendo: “Tu indichi il confine tra i popoli, le città e i grandi regni”. Georges Dumézil ha mostrato che nell’antichità indoeuropea il nome Terminus corrispondeva ad una caratteristica qualità del dio sovrano: la funzione di supremo tutore dei limiti territoriali.
Considerando che il primo numero della sua rivista Eurasia è stato dedicato alla Turchia, dove si colloca la Turchia nella sua teoria geopolitica?
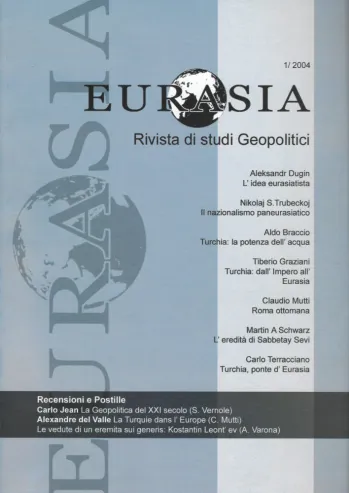
La regione chiamata con termine greco-bizantino Anatolia (“terra di levante”) nell’antichità fu considerata parte integrante dell’Europa: Erodoto infatti fissava il confine orientale dell’Europa sul fiume Fasi, nei pressi degli odierni porti georgiani di Poti e Batumi. Nel Medioevo Dante collocava “l’estremità dell’Europa” vicino ai monti dell’Asia Minore, dai quali, dopo la distruzione di Troia, l’Aquila imperiale spiccò il volo verso l’Italia. Nel secolo XIX il geografo Elisée Reclus diceva che l’Anatolia è una terra dell’Asia incastonata in un litorale europeo; e che, al tempo stesso, il suo territorio integra la parte sudorientale dell’Europa nella massa continentale eurasiatica. Se la penisola anatolica è la propaggine più occidentale dell’Asia, essa è al contempo la quarta penisola del Mediterraneo, nel quale occupa una posizione analoga a quella delle penisole greca, italiana e iberica; rispetto a quest’ultima, l’Anatolia occupa una posizione speculare, cosicché queste due penisole possono essere considerate le guardiane del Mediterraneo. Ma la Turchia non è solo Anatolia; la Turchia è anche Costantinopoli, ex capitale di quello che Arnold Toynbee chiamava “a Turkish Muslim Roman Empire”. Insomma, la Turchia è un paese tipicamente eurasiatico, poiché si estende sia in Asia sia in Europa. Perciò, quando si dice che la Turchia deve scegliere tra l’Europa e l’Asia, si presenta una falsa alternativa. A mio parere, la scelta alla quale è chiamata la Turchia, è quella tra l’Eurasia e l’Occidente.
In che modo il quadro geopolitico che ha sviluppato differisce dal concetto di eurasianismo di Aleksandr Dugin?
Nella prospettiva geopolitica di Dugin, il continente antico, ossia la massa terrestre dell’emisfero orientale, si articola in tre grandi “cinture verticali”, estese da nord a sud, nel senso dei meridiani terrestri: l’Eurafrica (Europa occidentale e centrale, grande spazio arabo, Africa transahariana), la zona russo-centroasiatica (ex URSS,Turchia, Iran, Afghanistan, subcontinente indiano), la zona del Pacifico (Cina, Giappone, Indonesia, Malesia, Filippine e Australia). Questa visione geopolitica “verticale”, che separa nettamente l’Europa dalla Russia, fu oggetto, sulle pagine di “Eurasia”, delle osservazioni critiche di Carlo Terracciano, il quale osservò che l’Eurasia è un continente “orizzontale”, poiché si estende nel senso dei paralleli. Traducendo questa constazione geografica in termini geopolitici, Terracciano, in contrasto con la visione di Dugin, prospettava l’integrazione della grande pianura eurasiatica settentrionale dal canale della Manica allo stretto di Bering. In una tale prospettiva, è naturale che l’Europa si integri in una sfera di cooperazione economica, politica e militare con la Russia, altrimenti essa sarà usata dagli Americani come un’arma contro la Russia. “Se ancora di Occidente ed Oriente si può e si deve parlare, – concludeva Terracciano – la linea di demarcazione deve essere posta tra i due emisferi, tra le due masse continentali separate dai grandi oceani”, cosicché il vero Occidente, la terra del tramonto, risulterà essere l’America, mentre l’Oriente, la terra della luce, coinciderà col Continente antico”.
Nonostante la sua concezione geopolitica “verticale”, contrastante con la visione di un comune destino eurasiatico, Dugin era tuttavia ben consapevole che l’Eurasia è oggetto dell’aggressione della talassocrazia statunitense, la quale è proiettata da sempre dalla sua stessa natura (e non semplicemente dall’orientamento di una parte della sua classe politica) verso la conquista del potere mondiale.
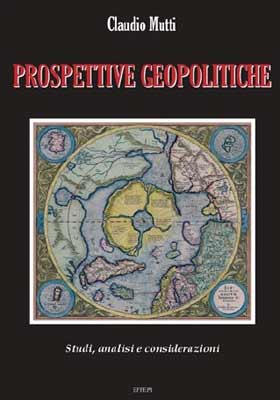
Ma nel 2016, quando ebbe inizio la prima campagna elettorale di Donald Trump, Dugin accantonò il punto di vista geopolitico e ne assunse uno prevalentemente ideologico, indicando il “nemico principale” nel globalismo liberale e accogliendo con sfrenato entusiasmo l’elezione del “conservatore” e “isolazionista” Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. “Per me – affermava Dugin nel novembre 2016 – è ovvio che la vittoria di Trump ha segnato il collasso del paradigma politico globale e, simultaneamente, l’inizio di un nuovo ciclo storico (…) Nell’età di Trump l’antiamericanismo è sinonimo di globalizzazione (…) l’antiamericanismo nell’attuale contesto politico diventa parte integrante della retorica della stessa élite liberale, per la quale l’arrivo di Trump al potere è stato un veero e proprio colpo. Per gli oppositori di Trump, il 20 gennaio è stato la ‘fine della storia’, mentre per noi rappresenta un varco per nuove opportunità ed opzioni”.
Procedendo su questa strada, il 3 gennaio 2020 Dugin arrivò al punto di augurare a Trump altri quattro anni di presidenza (“Four more years. Keep America great”); e questo nel giorno stesso in cui Trump rivendicava orgogliosamente l’assassinio del generale Soleimani. Adesso Dugin caldeggia una “nuova alleanza” tra la Russia e gli Stati Uniti. “I nemici della Russia – ha scritto il 20 maggio 2025 nel sito “Katehon” – sono i nemici di Trump e i nemici di Trump sono i nemici della Russia. Infatti, le nostre nuove relazioni [ossia le relazioni tra Russia e USA] dovrebbero essere costruite su questo rifiuto del globalismo. E forse anche la nostra nuova alleanza”.
Al di là dell’eurasiatismo, vorrei discutere l’idea di un’unione mediterranea. Crede che sia possibile creare un’unione del genere? Cosa prevede per il futuro dell’Italia e della Turchia nel contesto mediterraneo?
Essendo disseminato di basi militari della NATO e degli Stati Uniti d’America – da Malaga a Sigonella ad Alessandria d’Egitto a Smirne a Cipro – il Mare Mediterraneo è dalla seconda guerra mondiale una rientranza dell’Oceano Atlantico, un lago praticamente assoggettato alla superpotenza nordamericana. A ciò si aggiunge la presenza di un altro corpo estraneo, continua causa di destabilizzazione e di conflitti: il regime criminale sionista che da ottant’anni occupa il territorio palestinese. In una tale situazione, una “unione mediterranea” avrebbe un significato decisivo soltanto se il suo scopo fosse un’azione intrapresa per espellere dal “mare nostrum” queste presenze estranee. Ma quale paese mediterraneo può assumere un’iniziativa di questo genere? Certo, un ruolo di “prima linea” toccherebbe alle quattro penisole del Mediterraneo: Spagna, Italia, Grecia e Turchia. Quest’ultima, in particolare, occupa una posizione geograficamente cruciale, poiché la penisola anatolica, collocata al centro del grande complesso continentale, è il naturale crocevia tra l’Europa, l’Asia e l’Africa.
Dove convergono e divergono, secondo lei, il rivoluzionismo conservatore e il tradizionalismo? Pensa che questa linea di pensiero possa effettivamente sfidare o arrestare la progressione del liberalismo laico?
La formula della “rivoluzione conservatrice” (Konservative Revolution), nata in ambienti tedeschi dopo la prima guerra mondiale, intendeva indicare un’azione finalizzata ad eliminare una condizione di disordine per recuperare uno stato di normalità. Oggi però, considerando il livello toccato dalla cosiddetta “civiltà occidentale”, deve essere chiaro che in Europa è rimasto ben poco che potrebbe meritare di essere conservato. Quanto al concetto di rivoluzione, se esso deve essere inteso nel significato etimologico del termine, diventa inevitabile pensare ad un “ritorno” (revolutio) a quei princìpi fondamentali che sono stati negati dalla modernità. Ma allora il “tradizionalismo”, per avere un senso, non potrà essere concepito come l’ossequio a forme e istituzioni residue trasmesse dal passato, bensì come l’aspirazione ad un nuovo inizio. Perciò, più che una “rivoluzione conservatrice” bisognerebbe teorizzare una “rivoluzione tradizionale” ispirata da un “tradizionalismo rivoluzionario”.
Dagli anni ’80 in poi, gli atteggiamenti postmoderni hanno acquisito un notevole slancio. Crede che il postmodernismo abbia creato spazio per la riemersione della tradizione e del tradizionalismo, o piuttosto ne ha diminuito l’influenza?
La postmodernità non è il superamento del mondo moderno, bensì la sua fase suprema, nella quale il nichilismo si compie attraverso la sovversione della natura e la tecnologizzazione dell’uomo, che viene superato, sì, ma verso il basso, in direzione dell’infraumano. Se si vuole resistere a questo “ordine” artificiale ed invertito, occorre innanzitutto agire sulla propria coscienza, per essere in grado di respingere ogni inganno ed ogni seduzione, ogni tentazione di resa o di neutralità e quindi comportarsi di conseguenza. Che la fase culminante della modernità possa agevolare la riemersione della tradizione può apparire paradossale, ma in fin dei conti è una prospettiva obbligata, perché dallo spirito tradizionale può provenire la forza necessaria per rifiutare la sottomissione ad un mondo irreale.
Crede che potrebbe emergere un’identità europea musulmana, considerando che i sentimenti anti-islamici e anti-musulmani sono stati fattori significativi nel plasmare l’identità europea nel corso della storia? Come dovrebbero avvicinarsi la destra in ascesa e i musulmani in Europa?
Mentre la sinistra ha messo in atto un’insidiosa manovra di contaminazione delle comunità musulmane, da parte dei movimenti di destra non esiste nessuna reale volontà di avvicinarsi ai musulmani, né una propensione in tal senso. La destra, fondamentalmente occidentalista, assume posizioni strumentalmente favorevoli all’Islam soltanto nelle situazioni in cui si verifica un’occasionale convergenza tra musulmani e interessi dell’Occidente. Così è stato, ad esempio, in Afghanistan al tempo della guerriglia antisovietica o nella Jugoslavia dilaniata dagli scontri interetnici. Invece, nei casi in cui le posizioni di un popolo musulmano si scontrano con quelle dell’Occidente, troviamo la destra (fatta eccezione per qualche trascurabile frangia di estrema destra) puntualmente attestata su posizioni antislamiche. Certo, la destra europea potrebbe instaurare un’intesa o almeno un dialogo coi musulmani proponendo una difesa comune dei valori morali attaccati dalla cultura oggi dominante in Occidente. Perché non lo fa? O per ottusità, o per vigliaccheria, o perché ritiene che la demagogia pseudoidentitaria sia più redditizia in termini di risultati elettorali.
Ha intenzione di scrivere le sue memorie?
Trovandomi sulla soglia degli ottant’anni, dovrei scrivere le Confessioni di un ottuagenario. Ma un libro con questo titolo esiste già. Lo scrisse Ippolito Nievo tra il 1857 e il 1858.
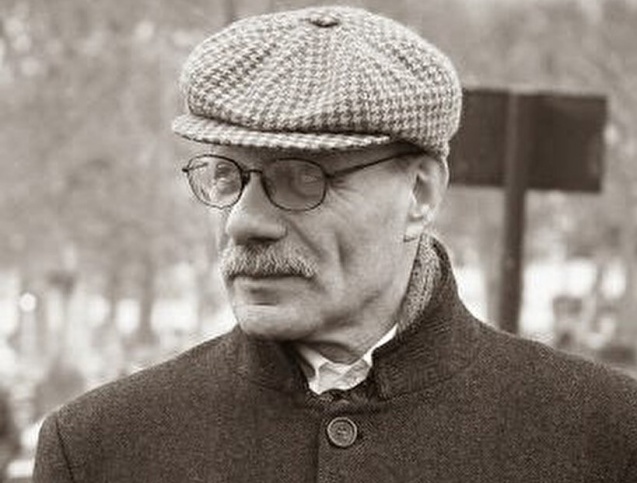
Mente lucida. Spirito baldo. Ironia beffarda. Claudio sorprende sempre.