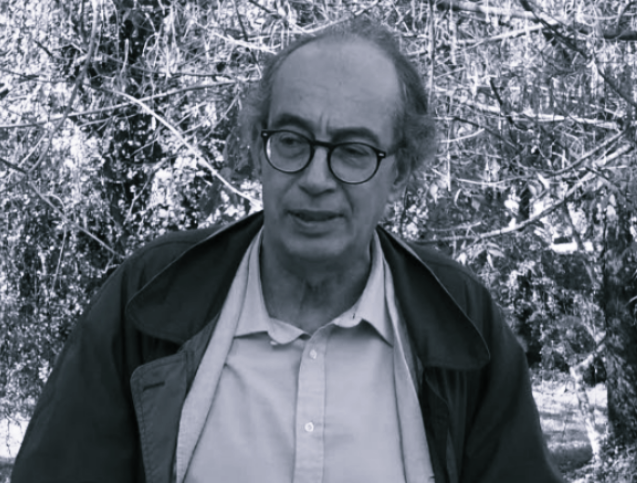In Italia esistono molti studi diversi nel campo della geopolitica. Qualunque sia l’approccio di base di questi studi, quando si parla di Turchia, l’interesse del pubblico italiano è sempre vivo. Sebbene il libro di Aldo Braccio Turchia, ponte d’Eurasia sia stato pubblicato nel 2014, è singolare che non ci sia stata una recensione significativa o un articolo di cronaca al riguardo nonostante siano passati 11 anni da allora.Abbiamo realizzato un’intervista con Aldo Braccio sul suo libro Turchia, ponte d’Eurasia.
Cominciamo a conoscerla. Come scrittore italiano, come è nato il suo interesse per la Turchia e cosa ha scoperto durante questo percorso? Cosa l’ha spinta a scrivere un libro sulla Turchia?

Il mio interesse e la mia considerazione per la Turchia nasce dall’amore per questa terra e per questo popolo: da 35 anni, con regolarità annuale, mi reco a visitare il Paese, a est come a ovest, comprovandone l’immutata ospitalità. A parte questo, la Turchia è estremamente interessante come crocevia di storia e di cultura che svela tante vestigia del Sacro e della Tradizione, con testimonianze plurime di civiltà diverse. Nel mio piccolo saggio e nei tanti articoli pubblicati sul tema Turchia ho cercato di porre in rilievo il ruolo importante, fondamentale di questa nazione nel dialogo fra le due parti del grande ecumene euroasiatico, ossia l’Europa e l’Asia. Chi invece non riconosce tale ruolo fondamentale, né riconosce l’unità essenziale del continente euroasiatico, mira ad ancorare la Turchia a un sistema “occidentale” a guida egemonica nordamericana in funzione antiasiatica e anche antiislamica , secondo i dettami di un insidioso “laicismo” relativista.
Nel suo libro fa riferimento alla “Profondità strategica” di Ahmet Davutoğlu. Sebbene l’interesse per quest’opera sia diminuito a causa degli sviluppi politici della Turchia di oggi, cosa l’ha attratta di questo libro? Ritiene che il concetto di “profondità strategica” sia ancora valido?
Ritengo che gli elementi fondamentali di Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararası konumu siano tuttora assolutamente validi, indipendentemente dall’evoluzione della carriera politica di Davutoğlu.
La Turchia si è trovata nella necessità di colmare in qualche modo il vuoto lasciato dalla scomparsa dell’impero ottomano, ricercando una continuità fra esperienza imperiale ed esperienza repubblicana, il che significa non pedissequa e anacronistica imitazione dell’impero bensì rispetto della propria illustre eredità storica e atteggiamento geopolitico propositivo. Per arrivare a ciò, ricorda nella sua opera Davutoğlu , occorre il formarsi di una comunità spirituale: “Uno Stato che non coltiva nel profondo un popolo, e che non plasma una comunità spirituale – sulla base di valori condivisi – non è altro che forza bruta”. Grazie alla sua posizione geostrategica, arricchita dalla sua profondità storica, la Turchia può avere un ruolo di ponte mediatore in una vasta area comprendente il Vicino e Medio Oriente, l’Europa mediterranea, il mar Nero e il centro Asia. Il principio di “zero problemi con i vicini” diventa fondamentale per rafforzare la centralità strategica della Turchia, per accrescerne ulteriormente l’autorevolezza; sul piano interno esso va tradotto – ed è stato positivamente tradotto, dai governi AKP – nel rispetto delle identità etniche e religiose presenti all’interno del territorio nazionale.
Nell’analisi di Stratejik derinlik, fra altri aspetti interessanti, si segnala quello dei “triangoli strategici”, che individua in Turchia, Iran ed Egitto – “bacino anatolico- mesopotamico settentrionale, bacino iranico-mesopotamico meridionale e bacino nilotico – i grandi attori regionali dell’area; all’interno di tale triangolo maggiore troverebbero armonica collocazione altri Stati costituenti triangoli minori. Davutoğlu nella sua opera segnala come particolarmente auspicabile per la Turchia la triangolazione con Iran e Siria, e oggi più che mai sarebbe opportuna la collaborazione fra questi Stati per fronteggiare le folli derive belliciste continuamente rilanciate dall’Occidente.
Perché la Turchia è un Paese così importante per il concetto di eurasiatismo? Con la sua posizione geopolitica e la sua prospettiva storica, qual è il ruolo strategico della Turchia nella regione eurasiatica e come si sta delineando?
La Turchia di per sé rappresenta una sorta di riassunto euroasiatico: vi sono infatti elementi europei ed elementi asiatici che convivono a fianco senza problemi . La storia antica dell’Asia Minore è intersecata con quella europea, greca in particolare; nell’attuale territorio turco sono nati Omero, Erodoto, Talete, Senofonte, Eraclito, Epiteto, Anassimandro, e potremmo continuare. Costantinopoli/Istanbul è la Seconda Roma, qui l’impero Romano proseguì il suo cammino eterno nella sua versione bizantina e poi in quella ottomana (per spostare poi la sua sede a Mosca, la terza Roma).
Il diplomatico e giornalista italiano Antonio Baratta scriveva nel 1831: “E’ cosa positiva, quantunque non tutti lo sappiano, che i turchi, lungi dal trattare i greci da nemici e da vinti, li colmarono in ogni tempo di grazie, di ricchezze, di onori. Senza parlare dei principi di Valacchia e di Moldavia, conservati sovrani, la nobiltà greca, superba abitatrice del Fanale (ndr: borgo di Costantinopoli vicino al mare), fu ammessa costantemente all’intima confidenza del Divano, ricoprì in ogni tempo le più alte cariche diplomatiche dell’impero, ammassò ricchezza immense nel loro esercizio e governò di fatto coloro medesimi che la governavano di nome”.
La Turchia ha rappresentato per la religione cristiana una vera e propria culla e un fondamentale centro di propulsione; l’Islam ha sempre convissuto con essa con grande rispetto e spirito di collaborazione.
Tutto questo per sottolineare l’importanza probabilmente impareggiabile della Turchia nel favorire il dialogo euroasiatico, l’incontro fra popoli e religioni diverse. Purtroppo da parte dell’Unione Europea si ha invece un’ostilità preconcetta e ideologica nei confronti di Ankara, che è funzionale ai piani occidentali e atlantisti, sempre pronti a sottomettere e a cancellare ogni pulsione di sovranità in giro per il mondo.
Ritiene che oggi sia necessaria un’unione mediterranea? Quali dovrebbero essere le basi teoriche per la creazione di tale unione e perché non è stata fortemente realizzata nella pratica? Quali ostacoli o opportunità esistono a questo proposito?
Penso che una Unione Mediterranea sia quanto mai opportuna, purché realmente autonoma e dotata di volontà politica. Certamente tale non è l’Unione per il Mediterraneo (UpM) istituita nel 2008 e per opinione comune fallita sotto ogni aspetto. Noi assistiamo oggi a un vero e proprio disastro mediterraneo, tra guerre, crisi economiche, povertà e flussi immigratori incontrollati, funzionali solo a chi sfrutta l’esercito di schiavi strappati alle loro terre.
La difesa delle identità mediterranee potrebbe essere la base teorica generale cui aggrapparsi, ma sarebbe necessaria, da parte soprattutto europea, consapevolezza di quali siano le proprie radici. Nei Paesi europei invece prevale la concezione occidentalista secondo cui il Vecchio Continente deve essere solidale innanzitutto con gli Stati Uniti d’America, seguendone “valori” e dettami. Ma gli Stati Uniti sono il principale responsabile del disastro mediterraneo: da una parte sfruttando e riducendo in miseria, con la globalizzazione, interi popoli – causando così le premesse dell’immigrazione selvaggia in corso – dall’altra con interventi militari e guerre sulla pelle dei popoli mediterranei (Palestina, Libia, Siria, Libano). A questo proposito risulta ovvio sottolineare che senza che sia resa giustizia all’oppresso, martoriato da oltre 70 anni popolo palestinese – vittima della criminale, ripetuta aggressione sionista – sarà ben difficile dare un equilibrio al mondo mediterraneo. Ma, anche qui, non sembra che i Paesi europei – e per la verità anche qualche altro Paese mediterraneo – siano molto sensibili alla questione, preferendo ripiegare sulla cosiddetta “sicurezza di Israele”. E’ necessario insomma ridare centralità e sovranità alla regione mediterranea, su basi nuove e più salde. Accennando alla Turchia, sarebbe necessario da parte europea un dialogo rispettoso e senza pregiudizi, in luogo della chiusura ideologica alquanto miope che essi dimostrano, fra l’altro andando anche contro i loro stessi interessi.
Guardando agli sviluppi della regione, quali giorni geopolitici attendono la Turchia?
Sono pienamente convinto che la Turchia sia consapevole dell’attuale fase geopolitica. In poche parole: il passaggio da un mondo unipolare – dominato dagli Stati Uniti, coi suoi alleati/sudditi al seguito, soprattutto Regno Unito, Unione Europea, Israele, quest’ultimo fondamentale sul piano ideologico/culturale e su quello del ricatto psicologico – a un mondo multipolare, più equilibrato e rispettoso delle diversità. La “globalizzazione” di marca americana ha causato infiniti danni al mondo intero favorendo invece la speculazione finanziaria e gli interessi di pochi, anzi di pochissimi.
Globalizzazione fa rima con frammentazione: la demolizione – con le buone o con le cattive – delle sovranità nazionali favorisce il dominio unipolare statunitense, che nell’area mediterranea/vicinorientale si traduce nell’arrogante predominio sionista. I recenti eventi in Siria ne sono purtroppo una tragica rappresentazione: la Turchia in questo senso ha un ruolo chiave e dovrebbe chiaramente schierarsi per la sovranità siriana – indipendentemente da chi sia al governo – e contro questo stato di guerra infinita che rende più deboli tutti i popoli dell’area, a esclusivo beneficio degli Stati Uniti e di Israele. La conflittualità turco-siriana – in particolare fra il 2012 e il 2016 – ha reso un pessimo servizio a tutto il Vicino Oriente, contraddicendo in pieno la dottrina della profondità strategica
D’altra parte non mancano – anzi, sono frequenti – le attestazioni della diffidenza e del disprezzo atlantista nei confronti della Turchia. Cito ad esempio – testualmente – il saggista francese Jean-François Colosimo a proposito di quelli che definisce i nuovi dispotismi : “Cina , Russia , Turchia , Iran e India vogliono spartirsi il mondo e sono accomunati dall’odio verso l’Occidente”; e addirittura: “La rinascita delle religioni, degli imperi e della barbarie sono la stessa cosa” ! Analogamente l’intellettuale americano Steve Bannon ha puntato il dito contro “tre nazioni – Turchia, Iran e Cina – frutto di civiltà antiche e pugnaci, ed estranee alla cultura giudeo-cristiana (…) i veri nemici sono a Pechino, Teheran e Ankara, e ci stanno aggredendo (sic) nel mar della Cina, nel Golfo e nel Mediterraneo “.
Chissà che non avesse ragione Samuel Huntington allorché nei 1996 si interrogava: “Cosa accadrebbe se la Turchia mutasse la propria identità ? Prima o poi potrebbe decidere di abbandonare il proprio umiliante e frustrante ruolo di mendicante che implora di essere ammesso in Occidente e riappropriarsi del ben più prestigioso ruolo storico di principale interlocutore islamico e antagonista dell’Occidente”. A distanza di anni, la richiesta stessa di fare parte di un’organizzazione come i BRICS dà un segno della consapevolezza turca del mondo che cambia e che è necessario cambiare.
Il pensiero politico in Italia è spesso attribuito a Machiavelli. Come si sta sviluppando il pensiero geopolitico nel suo Paese? Quali nomi o tendenze spiccano in questo campo?
Machiavelli, sì, è un illustre progenitore … Molti se ne ricordano come di un opportunista al limite del cinismo ma lui non scrisse mai che il fine giustifica i mezzi, semmai che nobili fini sono superiori ai mezzi. E scrisse anche che mantenere incorrotte le cerimonie religiose, e tenerle sempre in venerazione, è priorità assoluta di ogni Stato.
Vorrei ricordare chi diede vita alla disciplina geopolitica in Italia, Ernesto Massi, che tra il 1939 e il 1942 diresse assieme a Giorgio Roletto la rivista “Geopolitica”, fortemente voluta dal ministro dell’Educazione Nazionale Bottai. In merito al Mediterraneo, di cui prima abbiamo discusso, Massi scriveva che “l’unità mediterranea non è nei caratteri naturali dell’ambiente, ma è tenace creazione dell’uomo mediterraneo: non è geografia, è geopolitica”. Lo stesso Massi, che subì nel dopoguerra un’ingiusta epurazione durata una decina di anni, rilanciò negli anni Ottanta gli studi di geopolitica in Italia. Voglio ricordare anche il nome di Carlo Terracciano, che a cavallo tra il secolo scorso e l’attuale elaborò in chiave euroasiatista la dottrina geopolitica, con uno studio attento dei classici della geopolitica. Infine, senza trascurare i meriti della celebre rivista “Limes”, forse più ascrivibili al ramo della politica internazionale più che della geopolitica, segnalo gli studi dell’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) ed “Eurasia – rivista di studi geopolitici”, che da venti anni sotto la guida infaticabile di Claudio Mutti diffonde studi e analisi proponendo un’interpretazione della realtà politica mondiale multipolare; un approccio rivolto, più che a un universo, a un “pluriverso” che rispetti civiltà e identità diverse in una prospettiva di liberazione