Ho conosciuto Orazio Maria Gnerre attraverso “Materiali. Reinterpretare la Rivoluzione conservatrice” . È un giovane e prolifico accademico che continua la sua attività presso l’Università di Perugia. Interessanti anche le altre sue opere. Nihil Medium. Carl Schmitt tra passato e futuro, Morlacchi, Perugia 2024: Prima che il mondo fosse. Alle radici del decisionismo novecentesco (Before the World was: To the Roots of the Twentieth-century Decisionism), Mimesis, Milano 2018. Abbiamo discusso di rivoluzionarismo conservatore , Heiddeger, Ernst Jünger, Joseph de Meistre nel contesto del rivoluzionarismo conservatore. (L’intervista originale è in inglese)
Iniziamo col chiederle del suo libro Materiali. Reinterpretare la rivoluzione conservatrice, Editoriale Scientifica, Napoli 2021. Qual è lo scopo di quest’opera?
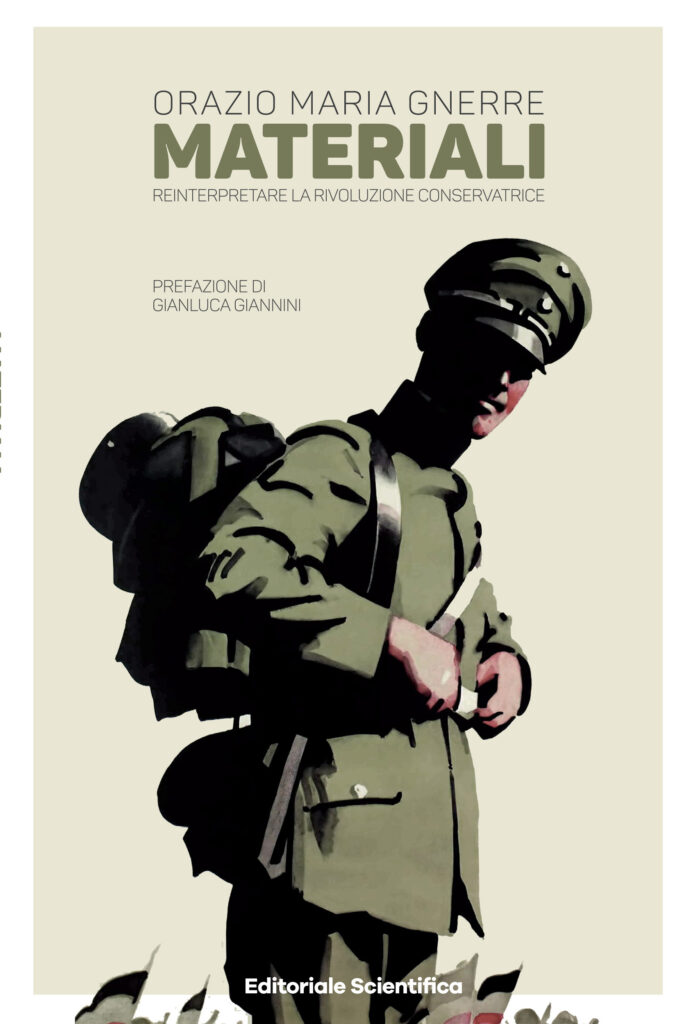
Il libro, pubblicato dall’Editoriale Scientifica nel 2021, mirava a riesaminare il fenomeno della Rivoluzione conservatrice tedesca dei primi decenni del Novecento, rileggendolo da altri punti di vista e prospettive. In particolare, il tema essenziale della ricerca proposta dal volume era quello di avvicinarsi al pensiero rivoluzionario-conservatore “scremandone” le idee fino a giungere al nodo centrale di questo filone di pensiero, che a mio avviso è il rapporto tra l’essere umano e la tecnologia, e dunque il grande tema della soggettività umana di fronte alle gigantesche trasformazioni imposte dalla modernità politica ed economica. Il titolo del libro, quindi, si riferisce precisamente all’elemento “materiale”, oggettivo e concreto, fondante i rapporti intersoggettivi e le trasformazioni politico-ideologiche secondo i pensatori della Rivoluzione conservatrice. In tal senso, ho voluto anche riformulare l’idea secondo la quale questa corrente di pensiero fosse una specificità idealistico-spiritualista: al contrario, vi è un’impronta “materialista” (non nel senso di “antireligiosa”, ovviamente, bensì fondata sull’analisi dei rapporti di potere reali) in questo discorso, e ho cercato di renderlo evidente nel capitolo sul rapporto tra la Rivoluzione conservatrice e il marxismo. Così facendo, ho per l’appunto “reinterpretato” il fenomeno, distanziandomi dall’idea che si tratti di una temperie generale del Novecento, e sostenendo piuttosto che il termine possa essere utilizzato per descrivere una vera e propria corrente filosofica sviluppatasi in Germania in quell’epoca, il cui nucleo essenziale è rappresentato dalla teoresi della triade Jünger-Schmitt-Heidegger.
Che cos’è in effetti la Rivoluzione conservatrice? Può darci una panoramica dei suoi principi di base e del contesto storico?

Il contesto storico di questo fenomeno culturale, che io interpreto come una vera e propria scuola di pensiero (al pari dell’idealismo tedesco, del marxismo, del postmoderno, ecc.), è quello della Germania dei primi decenni del XX secolo. Il pensiero di Ernst Jünger, notoriamente, gettò le basi per lo sviluppo di questa teoria identificando la trasformazione del mondo attraverso il grande dispiegamento materiale avvenuto con le “tempeste d’acciaio” della Prima guerra mondiale. Ci muoviamo su un livello di analisi simile a quello della nascita dell’industria moderna già colto dal pensiero di Marx, ma radicalizzato nella percezione non soltanto della capacità costruttiva, ma anche distruttiva della dimensione tecno-economica. Di fronte alla dimensione titanica delle grandi trasformazioni, l’essere umano era divenuto un puntino inerme che si lasciava trascinare da fenomeni di proporzioni colossali, inarrestabili, globali. Il compito del pensiero rivoluzionario-conservatore, a quel punto, era di restituire una dimensione di “sovranità antropologica” all’essere umano, conferendogli un senso e un fine per superare un’impasse storico-filosofica che sembrava (e sembra tuttora) insormontabile. Sul tema della sovranità intesa come dimensione antropologica radicale – tema centrale all’inizio del Novecento e specialmente nella riflessione rivoluzionario-conservatrice – desidero anche segnalare le mie riflessioni in Prima che il mondo fosse. Alle radici del decisionismo novecentesco, Mimesis, Milano 2018.
Dal punto di vista del conservatorismo rivoluzionario, perché Joseph de Maistre criticò fortemente il liberalismo? Come possiamo identificare la cosiddetta “destra liberale” rispetto alle critiche di de Maistre?
Joseph de Maistre, pensatore conservatore a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, criticò con forza il liberalismo nella sua dimensione antropologica e spirituale, in quanto forza disgregatrice, che si opponeva in sostanza a qualsiasi forma di ordine politico e, appunto, spirituale dell’umanità. Questo discorso, che naturalmente si muoveva su un piano problematico molto diversi rispetto a quello poi affrontato dalla Rivoluzione conservatrice tedesca, trovò comunque spazio di riflessione in quel successivo contesto. In particolare, l’analisi di Schmitt prese in considerazione il pensiero del Conte savoiardo, scorgendovi una serie di questioni riguardanti il rapporto tra pubblico e privato, tra discussione e decisione, questioni che costituivano, secondo il Giurista di Plettenberg, la base del cosiddetto “pensiero della Controrivoluzione”. Tale pensiero aveva, secondo Schmitt, in larga parte anticipato alcune tendenze storiche (talvolta, perfino di natura geopolitica-internazionalistica). Nel mio saggio già citato sul decisionismo novecentesco ho discusso a lungo le influenze dirette e indirette del pensiero di De Maistre e di Rousseau sul pensiero della critica antiliberale del XX secolo, mostrando come il Conte in molti modi si sia rivelato anticipatorio rispetto a questioni che sarebbero esplose in seguito.
Per quanto riguarda il tema della “destra liberale”, è interessante notare come la critica di De Maistre al liberalismo fosse così radicale da porsi ben al di fuori dello schema repubblicano moderno di destra e sinistra. De Maistre era già un sostenitore dell’idea della globalità della politica e della sua organizzazione in schemi civilizzazionali, quindi l’opposto della distribuzione delle idee in campi interni quali “destra” e “sinistra”. Nei suoi testi ed in quelli dei suoi allievi ed epigoni vengono criticate molte nozioni vicine a ciò che oggi definiremmo “destra liberale”, a cominciare dal principio della proprietà privata inalienabile.
Quali sono le idee del filosofo del XX secolo Heidegger che lo rendono un “rivoluzionario conservatore”? In che modo la sua filosofia ha supportato l’idea della Rivoluzione conservatrice?
Molto sinteticamente, è la questione della tecnica che, a mio avviso, rende Heidegger un rivoluzionario conservatore, e in particolare uno dei tre pensatori chiave di questa corrente filosofica. Ciascuno dei tre, secondo la mia analisi, aveva una prospettiva differenziata sugli esiti possibili della ridefinizione degli spazi d’influenza tra la tecnica moderna e la sovranità umana, ma tutti ragionavano in modo simile sulle questioni centrali di questa “battaglia”. Il tema della tecnica, che in Heidegger è strettamente intrecciato a quello della storia della filosofia e della metafisica occidentale, assume l’aspetto della misura del nichilismo crescente nella società contemporanea, e si manifesta come un’enorme questione di carattere destinale. È proprio ciò a rendere questo autore un pensatore della Rivoluzione Conservatrice. La sua idea essenziale, e il suo contributo alla dimensione speculativa di questa corrente, era la necessità di ristabilire un ordine del linguaggio per accogliere una grande trasformazione, che sarebbe giunta da un grande movimento di rivelazione ontologica.
Come valuterebbe l’interazione tra Heidegger e Jünger, e come i due pensatori si sono influenzati a vicenda? Qual e il loro posto nel pensiero rivoluzionario-conservatore? In particolare, quali sono i loro approcci diversi alla questione della tecnica?
Com’è noto, entrambi questi pensatori interagirono su vari livelli fino a confluire nella stesura del famoso testo Über die Linie. Come sappiamo, si trattava di un dialogo sul ruolo della tecnica nell’epoca contemporanea e sulla dissipazione e superamento della fase nichilistica. All’interno di questo confronto, composto da due saggi, i due pensatori esposero un approccio differente alla questione: nell’interpretazione del diverso significato del titolo (da una parte “sulla linea”, dall’altra “oltre la linea”) sta la differenza nell’approccio di Heidegger e Jünger. Jünger riteneva che l’essere umano e la sua civiltà avessero già iniziato a superare la fase nichilistica, mentre Heidegger credeva che il nichilismo fosse ancora la figura dominante della nostra esistenza. Proprio in questo interregno l’essere umano avrebbe dovuto prepararsi ed attendere l’evento che avrebbe ridischiuso la percezione dell’Essere. Questi diversi approcci, tuttavia, gravitavano attorno allo stesso fulcro tematico che rappresenta la chiave di lettura dell’intera scuola di pensiero della Rivoluzione conservatrice: il binomio tecnica-nichilismo. È su questa base che possiamo considerare entrambi i pensatori come filosofi della Rivoluzione conservatrice.
Il “conservatorismo rivoluzionario” è in crescita oggi?
Sì, e no. Se consideriamo in maniera estensiva il concetto di “rivoluzione conservatrice” quale tendenza che in qualche modo unisce l’epoca contemporanea e le tradizioni culturali, o più in generale una visione non nichilista dell’esistenza, possiamo dire che un risveglio di questo tipo di coscienza si stia verificando su più livelli e in più parti del mondo. In un certo senso, possiamo osservare come si stia giungendo ad un esaurimento di determinate teorie o approcci filosofici e culturali che hanno caratterizzato la modernità politica, sociale ed ideologica. Questi approcci e teorie si stanno affinando e disvelando completamente nella dialettica culturale, e così facendo generano le proprie antitesi. Eppure, siamo ancora in un confronto epocale con le distorsioni problematiche imposte dal potere eccezionale della tecnica, e con la centralizzazione delle risorse tipica della società capitalistica. Possiamo dunque affermare che siamo ancora del tutto immersi in questa contraddizione sociale e filosofica, che i rivoluzionario-conservatori avevano messo in luce all’inizio del secolo scorso. In questo senso, la questione si ripropone, come già detto, in un movimento dialettico della storia che si articola in affermazioni e negazioni dei due grandi elementi identificati dalla Rivoluzione conservatrice come polarità opposte: il soggetto umano e la sua negazione. Leggere Über die Linie in tale prospettiva può fornirci alcune categorie utili ad interpretare l’attuale fase storica.
