Quando mi sono imbattuto in questa frase di Jalal Al-e Ahmad su Ernst Jünger, ne sono rimasto profondamente colpito: «Jünger e io stavamo studiando più o meno lo stesso argomento, ma da due punti di vista diversi. Affrontavamo la stessa questione, ma in due lingue diverse». Partendo da questa affermazione, abbiamo discusso con Alessandra Colla di Eurasia Rivista come i due pensatori abbiano affrontato questioni comuni provenienti da contesti culturali e intellettuali diversi, nel quadro della rivoluzione conservatrice e del Gharbzadegi.
Jalal Al-e Ahmad rimane un pensatore le cui opere e concetti sono ancora oggi oggetto di dibattito. Potrebbe parlarci della sua vita e delle trasformazioni nel suo mondo intellettuale? Quali fattori hanno innescato questi cambiamenti?
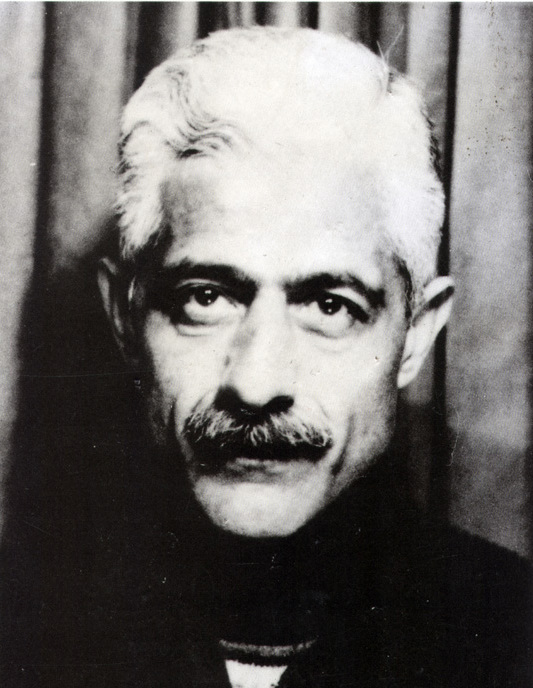
In Italia Jalal Al-e Ahmad è pressoché sconosciuto al di fuori degli ambienti specialistici. Eppure questo pensatore è una figura centrale nel panorama della storia intellettuale iraniana del XX secolo, tanto da essere annoverato tra gli ispiratori della Rivoluzione del 1979.
La sua vita s’intreccia profondamente con la storia travagliata dell’Iran del XX secolo: difficile raccontarla compiutamente in un’intervista, così mi limiterò a tratteggiarla per sommi capi.
Nato a Teheran nel dicembre 1923 da una famiglia sciita di tradizione clericale da tre generazioni, avverte presto la tensione tra la visione del mondo religiosa e la trasformazione radicale della società iraniana sotto Reza Pahlavi, lo scià al potere dal 1925. Avviato agli studi teologici, li abbandona dopo soli tre mesi e rompe i rapporti con la famiglia rifiutandone i valori religiosi. Nel 1944 si iscrive al Tudeh, il partito comunista iraniano di orientamento marxista (fondato nel 1941) e nel 1946 si laurea in Letteratura persiana presso il Tehran Teachers College, deciso a dedicarsi all’insegnamento. Intanto la sua carriera politica decolla, portandolo a diventare, nel giro di pochi anni, membro del Comitato centrale, poi delegato al congresso nazionale e infine direttore della casa editrice del partito. In questa veste inizia a pubblicare le sue raccolte di racconti finché, nel 1947, ottiene l’abilitazione all’insegnamento; nello stesso anno abbandona il Tudeh, a cui rimprovera il dogmatismo stalinista. Il suo esempio viene seguito da altri, e su ispirazione di Khalil Maleki – intellettuale e politico della sinistra iraniana – i dissidenti danno vita al Partito Iraniano dei Lavoratori.
Ma nel 1948 il Tudeh conosce un’altra scissione, dalla quale nasce Terza Forza: un movimento politico per lo sviluppo indipendente dell’Iran, che si propone di coniugare il nazionalismo con una forma di socialismo democratico e centrismo marxista, distanziandosi così sia dall’influenza occidentale sia da quella sovietica. Al-e Ahmad vi aderisce subito dopo aver abbandonato il Partito Iraniano dei Lavoratori, ma il movimento si dissolve nel 1953 con il colpo di stato – orchestrato da Stati Uniti (CIA) e Gran Bretagna (MI6) – che riporta al potere Mohammad Reza Pahlavi, sul trono dal 1941 e momentaneamente in esilio a Roma. Nello stesso anno Al-e Ahmad si ritira definitivamente dalla militanza e nel decennio successivo si dedica all’insegnamento, alla letteratura (come autore e come traduttore dal francese di opere di Camus, Gide, Ionesco e Sartre) e alla ricerca etnografica nell’Iran settentrionale e nel Golfo Persico. Qui scopre il mondo, per lui finora sconosciuto, del sottoproletariato contadino, ricco di valori riconosciuti come arcaici eppure di gran lunga superiori a quelli fittizi imposti dalla modernità: l’esperienza lo segna profondamente, contribuendo in modo decisivo all’ultima svolta intellettuale della sua vita, come si vedrà.
Fino al 1968 viaggia molto (Stati Uniti, URSS, Israele, Arabia Saudita), pubblicando resoconti accurati e critici delle sue esperienze. Di estrema importanza è il viaggio alla Mecca, compiuto nel 1966, in seguito al quale Al-e Ahmad proclama il ritorno alle origini rivalutando appieno l’Islam in generale e lo sciismo in particolare, visto ora come l’unica possibile cura contro l’“infezione occidentale” che affligge l’Iran. Scrive un’ultima opera, pubblicata postuma nel 1978: “Sul servizio e il tradimento degli intellettuali” (Dar khedmat va khianat roshanfekran), una veemente denuncia del disimpegno degli intellettuali iraniani: il riferimento a Il tradimento dei chierici. Il ruolo dell’intellettuale nella società contemporanea di Julien Benda, uscito nel 1927, è trasparente.
Al-e Ahmad muore nel settembre 1969 nella sua casa, per un attacco cardiaco, ma comincerà presto a girare la voce (ancora infondata) che sia stato eliminato dalla Savak, la polizia segreta dello scià.
Il primo concetto che viene in mente quando si pensa a Jalal Al-i Ahmad è quello di “Occidentosi” (Gharbzadegi). Potrebbe spiegarne il significato e il contesto?
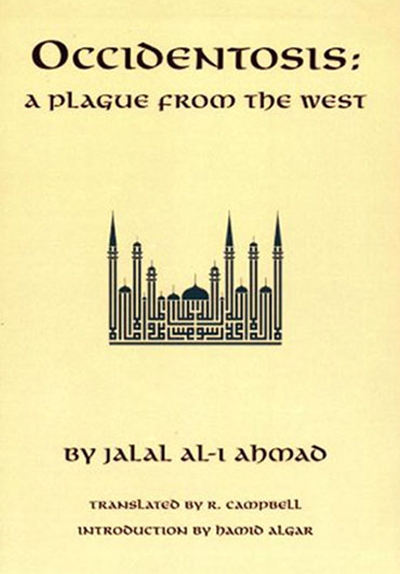
Al-e Ahmad scrive Gharbzadegi nel 1961, facendolo circolare clandestinamente. Il libro, pubblicato nel 1962, viene subito sottoposto a censura e ritirato dalle librerie. Il titolo è molto particolare: lo si traduce generalmente come Occidentosi, più corretto di Occidentite. In medicina, infatti, il suffisso “-ite” indica l’infiammazione che colpisce un organo o un apparato: ma Al-e Ahmad non vuole parlare dei mali di cui soffre l’Occidente. Al contrario, vuole stigmatizzare l’Occidente come male che affligge il non-Occidente, ed è per questo che Occidentosi è più calzante come traduzione: in medicina il suffisso “-osi” indica “un’affezione degenerativa” oppure “una condizione o uno stato”, e infatti l’autore intende dire che l’Iran – e in generale il mondo non-occidentale – sono “malati di Occidente”.
Bisogna chiarire che il termine gharbzadegi non è un conio originale di Al-e Ahmad, che lo prende invece in prestito dal filosofo Seyed Ahmad Fardid (1909-1994), studioso di Heidegger e considerato uno degli ispiratori del governo islamico salito al potere nel 1979. Fardid muove la sua critica all’Occidente su un piano squisitamente filosofico e segnatamente ontologico: denuncia esplicitamente il dominio sul pensiero metafisico esercitato dalla tradizione filosofica occidentale per 2500 anni, che ha portato all’oblio della dimensione intuitiva e spirituale in favore della pura ragione distaccata dalla verità dell’essere.
Al-e Ahmad, invece, adotta il termine attribuendogli però una valenza differente. Più precisamente, paragona l’Occidentosi a un’infestazione di tarme che corrode dall’interno un tappeto persiano: la forma resta intatta, ma la sostanza viene impoverita e svuotata rendendo il tappeto fragile e privo di valore. L’Occidente grava sull’identità iraniana non come semplice colonialismo politico (pur con tutti i suoi mali), ma come colonizzazione di conquista e sfruttamento che distrugge mentalità, costumi, cultura ed economia, assoggettando un intero popolo e facendo di una nazione un guscio vuoto. Come è stato possibile arrivare a questo? La risposta è tanto semplice quanto dolorosa: la responsabilità ricade sulla classe dirigente iraniana – scià e intellettuali insieme –, che si è piegata servilmente alla “civiltà” occidentale. Nell’inutile tentativo di imitarla, ha accettato la distruzione dell’artigianato locale, l’alienazione culturale, la perdita dei valori tradizionali: la conseguenza è stata una catastrofica, umiliante dipendenza economica e tecnologica che ha consegnato l’Iran al Terzo mondo.
È proprio questa interpretazione che Fardid rimprovera ad Al-e Ahmad, accusandolo di banalizzare un fenomeno dal profondo impatto civilizzazionale. In realtà, spostando il concetto di “Occidentosi” dal piano della critica ontologica a quello della diagnosi politica e socioeconomica Al-e Ahmad è riuscito a rendere questo concetto accessibile a un pubblico più ampio, trasformandolo in un potente vettore anticoloniale capace di galvanizzare il dissenso e influenzare significativamente l’opposizione che avrebbe poi portato alla Rivoluzione del 1979.
Ma Al-e Ahmad non si limita a denunciare il problema, anzi ne suggerisce anche la soluzione, individuandola in una “terza via” in grado di affrontare la modernità tecnologica senza cederle e senza negarla: l’Iran può e deve acquisire il controllo della tecnica e diventare esso stesso produttore attivo invece che semplice consumatore passivo. Naturalmente, anche questa opzione non è scevra da problemi: una volta superata l’“Occidentosi”, il rischio maggiore è rappresentato da quella che potremmo chiamare “macchinosi”, ovvero una “intossicazione da macchine”. Per questo, dice Al-e Ahmad, è fondamentale considerare la macchina (la tecnica) un mezzo e non un fine: il mezzo per salvaguardare la libertà e la dignità dell’Iran e del suo popolo.
A questo punto, emerge un’altra domanda: chi sarà il soggetto ideale in grado di intraprendere la “terza via”? Sorprendentemente, Al-e Ahmad individua questo soggetto nell’Islam sciita duodecimano, unico elemento non affetto da “Occidentosi” e anzi geloso custode della tradizione iraniana. Profondamente convinto dell’inadeguatezza degli intellettuali, Al-e Ahmad ritiene invece che il clero sciita, forte della sua integrità, possa mobilitare le masse con successo per richiamarle alla riscoperta della più genuina identità persiano-islamica.
Prevedibilmente, questa presa di posizione suscitò, a suo tempo, polemiche e critiche: al di là delle accuse di tradimento, è innegabile che la visione di sovranità nazionale e autosufficienza offerta da Al-e Ahmad sembra mancare di rigore filosofico e linee-guida per l’attuazione pratica. Di fatto, questa non voluta ambiguità avrebbe poi prestato il fianco all’emergere incontrollato di un islamismo e un anti-imperialismo fine a sé stessi e non incanalati nell’alveo di un’azione politica strutturata.
Nel suo libro Occidentosi, Jalal Al-i Ahmad cita Ernst Jünger dicendo: “Jünger ed io stavamo entrambi esplorando più o meno lo stesso argomento, ma da due punti di vista. Stavamo affrontando la stessa domanda, ma in due lingue.” Come si sono incrociati intellettualmente Ahmad e Jünger? Perché Ahmad si sentiva vicino a Jünger?
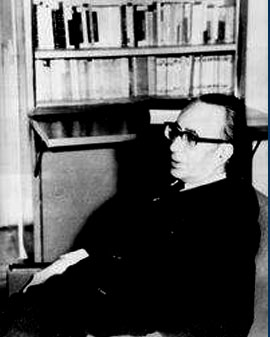
Sappiamo che la connessione intellettuale tra Al-e Ahmad e Jünger non fu diretta, ma mediata attraverso il pensiero di Martin Heidegger, a sua volta veicolato in Iran da Fardid. Heidegger (che a Jünger dedicò anche un seminario nel 1939-40) vedeva in Jünger il critico più acuto dell’epoca moderna, il pensatore che meglio di tutti aveva saputo analizzare e diagnosticare clinicamente l’essenza della tecnica, pur senza coglierne il fondamento metafisico. In particolare, l’attenzione di Heidegger si era soffermata su due testi capitali di Jünger, La mobilitazione totale (Die totale Mobilmachung, 1930) e L’Operaio. Dominio e forma (Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, 1932).
Li richiamo brevemente. Per Jünger, dopo l’esperienza radicale della Prima guerra mondiale la “mobilitazione totale” non riguarda più soltanto la sfera economica e militare, ma investe l’intera società diventando il principio organizzativo fondamentale del mondo moderno, in cui tutte le energie, le risorse, le tecnologie e gli esseri umani stessi vengono appunto “mobilitati”, ossia organizzati e inquadrati al servizio di un unico gigantesco processo produttivo, uguale a sé stesso in pace e in guerra. L’Operaio, nella sua duplice dimensione di lavoratore-soldato, incarna il nuovo tipo umano scaturito dall’esperienza bellica come protagonista-strumento della volontà di potenza espressa dalla Tecnica: in pace è addetto al funzionamento della macchina, come in guerra era stato il servente al pezzo d’artiglieria. Sottolineo che in italiano si è scelto di tradurre il tedesco Arbeiter con “operaio” e non come “lavoratore”, perché “operaio” identificare immediatamente chi lavora nella fabbrica, simbolo stesso della modernità industriale e capitalistica. Mantengo anche l’iniziale maiuscola perché nel discorso jüngeriano “Operaio” e “Tecnica” sono figure metafisiche.
Lo studio dei testi di Jünger permise a Heidegger di elaborare il concetto fondamentale di Gestell, “impianto”, individuato come l’essenza della tecnica moderna. Il Gestell non è una singola macchina o un apparato, ma il modo in cui vengono disposte le cose e la realtà (esseri umani, animali, natura) nel nostro tempo, privandole di senso o valore ontologico e facendone un semplice Bestand, “risorsa” per le esigenze della tecnica. Così, per esempio, un fiume o un lago sono una risorsa per la centrale idroelettrica, una foresta è una risorsa per l’industria del legname, un essere umano è una risorsa per l’azienda.
Come Jünger, dunque, anche Al-e Ahmad individua nella tecnica – possesso della macchina e controllo della stessa – la cifra distintiva della modernità, che spersonalizza l’essere umano svuotandolo di ogni spiritualità e spalancando le porte al nichilismo. La dipendenza dell’Iran dalle macchine è appunto l’“Occidentosi”, che minaccia l’esistenza stessa del singolo e del popolo, annientandone l’identità in perfetta conformità con il progetto colonialista.
Esistono parallelismi tra il concetto di “Occidentosi” e la prospettiva della Rivoluzione Conservatrice riguardo alla guerra e alla tecnologia, cultura ecc.? Si può parlare di un’alleanza intellettuale in questo caso?

Riprendo la frase di Al-e Ahmad citata più sopra: «Jünger ed io stavamo entrambi esplorando più o meno lo stesso argomento, ma da due punti di vista. Stavamo affrontando la stessa domanda, ma in due lingue». Ecco, l’espressione “in due lingue”, a mio avviso, va interpretata proprio come “in due linguaggi” diversi.
Tra Jünger ed Al-e Ahmad c’è senz’altro una consonanza, più o meno marcata, nella percezione della Tecnica come forza distruttiva: per il tedesco, essa è un’istanza autonoma e planetaria che annichilisce l’individuo come persona trasformandolo in Operaio, ossia un tipo umano standardizzato e intercambiabile, senza volto, che ha perso il contatto con la natura e la tradizione; per l’iraniano, la tecnica è uno strumento di colonizzazione culturale ed economica che distrugge le identità locali trasformando le persone in individui senza radici, che disprezzano la propria cultura tradizionale ma allo stesso tempo non riescono a integrarsi nella cultura dell’Occidente dominante.
Diversa, invece, è la situazione per quanto concerne lo sguardo globale sulla storia e la proposta di soluzione (ammesso che ce ne sia una).
Jünger, come sappiamo, è un esponente di spicco della Rivoluzione Conservatrice: nella sua visione elitaria e anti-borghese, la storia è un processo metafisico di affermazione della volontà di potenza, che nel XX secolo sfocia nel dominio della Tecnica. La concezione di Al-e Ahmad è assai differente: terzomondista e anti-colonialista, legge la storia come lotta di popolo per l’emancipazione dal dominio occidentale.
A partire da queste premesse, i due pensatori sviluppano un progetto coerente per sottrarsi alla modernità. Per Jünger, che coltiva una visione individualista, la soluzione sta in quello che lui stesso chiama “passaggio al bosco” (Waldgang): una resistenza interiore, aristocratica e solitaria – nichilista –, che non prevede l’organizzazione di movimenti o strutture articolate ma, tutt’al più, il “riconoscersi” tra simili, rifiutando nettamente un impegno di tipo collettivo. Al-e Ahmad, al contrario, prefigura proprio un ritorno collettivo – spirituale e identitario – all’Islam sciita, elemento centrale immune all’“Occidentosi” e pertanto unico baluardo culturale e politico in funzione anti-occidentale; queste idee, infatti, contribuiranno significativamente all’impianto ideologico della Rivoluzione del 1979.
Alla luce di queste considerazioni, mi sembra quindi corretto parlare non tanto di “alleanza intellettuale” quanto, piuttosto, di “convergenza critica” sul terreno della critica alla modernità. Per entrambi i pensatori l’Occidente novecentesco è un anti-modello sotto ogni aspetto, in particolare per quanto riguarda la Tecnica, sorta di tritacarne metaforico che inghiotte la persona dotata di specificità per restituirla sotto forma di ammasso organico indifferenziato. Ma i progetti ideologici di cui si fanno portatori il tedesco e l’iraniano divergono radicalmente, anche perché radicalmente diverso è il contesto in cui si muovono: entrambi guardano con occhio critico alla modernità e alle problematiche a essa connesse, ma Jünger lo fa da un punto di vista interno all’Occidente, mentre Al-e Ahmad lo fa da un punto di vista esterno, da colonizzato.
In conclusione, credo si possa dire che Al-e Ahmad accoglie questa parte del complesso pensiero di Jünger come uno strumento prezioso, utile per lo sviluppo di una critica della modernità – con i suoi corollari di liberalismo e razionalismo – ben strutturata e orientata al recupero dell’autenticità culturale di un intero popolo.
Lei scrive anche per “Eurasia Rivista”. Come si sta sviluppando il pensiero geopolitico in Italia? Quali figure o correnti si distinguono in questo campo? In particolare, chi sono i nomi più rilevanti negli studi geopolitici italiani degli ultimi anni?
Dal secondo dopoguerra l’Italia – a differenza di altri paesi come Francia o Regno Unito, per esempio – non ha avuto una forte scuola geopolitica accademica autonoma: la disciplina era infatti associata al fascismo (epoca in cui eminenti studiosi come Ernesto Massi e Giorgio Roletto dedicavano la loro attenzione al Mediterraneo) e per questo stigmatizzata. Ancora oggi viene spesso insegnata come parte delle facoltà di Scienze politiche, Relazioni internazionali o Storia.
In Italia il dibattito più vivace – molto influenzato dalle appartenenze politiche e ideologiche –avviene generalmente fuori dalle università, nei think tank o su riviste e giornali; i protagonisti sono molto spesso giornalisti, analisti ed ex diplomatici.
Si possono individuare, a grandi linee, quattro correnti.
La prima, dominante, è quella atlantista-europeista, allineata con la posizione ufficiale italiana nell’ambito della NATO e dell’UE. È prevalente nel ministero degli Esteri, negli ambienti militari e finanziari, e nei partiti di centro-destra e centro-sinistra moderati. Vede la NATO come pilastro fondamentale della sicurezza nazionale ed europea, appoggia l’integrazione europea, sostiene la partnership transatlantica, contempla un cauto interventismo umanitario o di stabilizzazione. Vi fanno capo l’Istituto Affari Internazionali (IAI) e l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Fra i nomi spiccano quelli del generale Carlo Jean e di Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI) e consulente di governo.
La seconda corrente è quella sovranista/nazional-conservatrice. Emersa con l’ascesa dei due partiti Lega (leader Matteo Salvini) e Fratelli d’Italia (leader Giorgia Meloni), puntava a ristabilire la sovranità nazionale e gli interessi italiani in primis, criticando l’UE burocratica e federalista, predicando un realismo spinto negli interessi nazionali, manifestando un concreto scetticismo nei confronti della NATO in quanto strumento di egemonia USA e dichiarando l’apertura al dialogo con Russia e Cina. Ho usato l’imperfetto perché queste idee appartengono al periodo in cui Lega e Fratelli d’Italia erano all’opposizione: ora che sono al governo si sono appiattiti sulla linea mainstream, mostrandosi nei fatti ancora più atlantisti e legati agli Stati Uniti e ai loro interessi, a scapito degli interessi nazionali. La rivista di riferimento è “Analisi Difesa” e fra i nomi, merita di essere ricordato quello del suo direttore, Gianandrea Gaiani.
Poi c’è la corrente che potremmo definire realista (o neo-realista): più accademica e analitica, riconosce la sostanziale anarchia del sistema internazionale ed esamina le relazioni internazionali sulla base dei rapporti di forza (economica e militare). Lucidamente critica verso l’atlantismo, non lo rigetta ma sostiene comunque il primato degli interessi nazionali; nutre un certo scetticismo verso gli interventi umanitari e ritiene necessario che l’Italia si doti di una “grand strategy” a lungo termine (obiettivo a mio avviso irrealizzabile finché l’Italia resterà sotto l’ombrello NATO/UE). La rivista di riferimento è l’autorevole “Limes”, fondata e diretta da Lucio Caracciolo; altri nomi di rilievo sono Dario Fabbri e Giulio Sapelli.
Quarta, la corrente che potremmo definire terzomondista/anti-imperialista e anti-colonialista, radicata nella sinistra comunista e anti-americana, fortemente critica nei confronti dell’egemonia occidentale e della NATO come strumento aggressivo degli Stati Uniti; sostiene i movimenti di liberazione nazionale e la causa palestinese. I referenti principali sono Manlio Dinucci e Alberto Negri: il primo è giornalista del quotidiano “il Manifesto”, il secondo vi collabora.
Infine, una realtà a sé è rappresentata dalla rivista “Eurasia”, oggi difficilmente etichettabile da un punto di vista ideologico: la sua linea esplicitamente anti-atlantista, anti-globalista, anti-colonialista e anti-sionista è infatti, come abbiamo visto, condivisa anche da altre correnti geopolitiche; un altro dei suoi punti di forza è l’attenzione riservata al Sud del mondo e oggi ai BRICS, con un focus sul Medio Oriente (questione palestinese in primis) e l’Asia centrale.
Fondata nel 2004 da Claudio Mutti e Carlo Terracciano (uno dei primi e più acuti studiosi di geopolitica del dopoguerra, scomparso prematuramente proprio vent’anni fa, nel settembre 2005), “Eurasia” si propone sia di promuovere studi e ricerche di geopolitica a livello accademico, sia di sensibilizzare il pubblico (specialistico e non) sulle tematiche eurasiatiche: laddove per Eurasia s’intende il continente eurasiatico dalla Groenlandia (a ovest) al Giappone (a est).
La riscoperta dell’unità spirituale dell’Eurasia – così come, nel corso del tempo, si è espressa in molteplici forme culturali – rappresenta non soltanto un fattore innovativo nel panorama degli studi geopolitici, ma costituisce una valida alternativa alle teorie ormai obsolete della “fine della storia” e dello “scontro di civiltà” elaborate rispettivamente da Francis Fukuyama e da Samuel Huntington alla fine del XX secolo. Benché di nicchia, “Eurasia” può contare su un pubblico fedele e su una cerchia di collaboratori qualificati.
